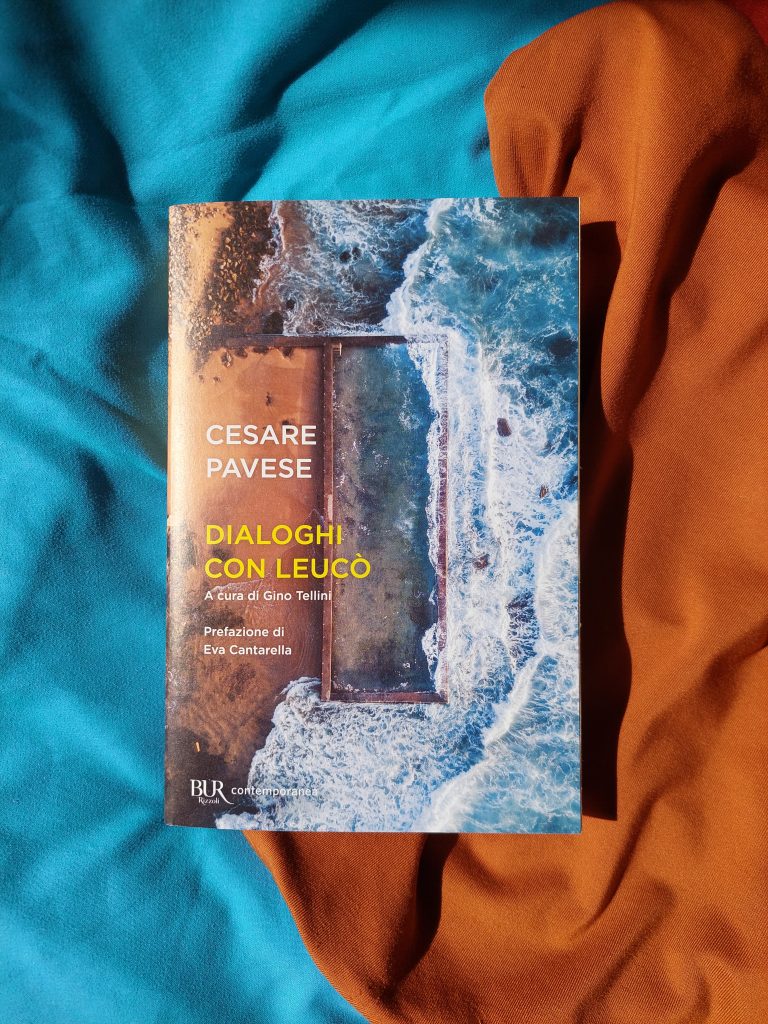
Credo in ciò che ogni uomo ha sperato e patito. Non penso esistano parole più efficaci di queste – queste, pronunciate dal primo interlocutore nel pezzo intitolato Gli dèi – nel condensare il senso ultimo del mito e, insieme, il senso ultimo di questi Dialoghi con Leucò, impresa maestosa compiuta da Pavese, trionfo commovente di grecità e umanità.
Grecità e umanità. Perché insieme?, vi potreste chiedere.
Perché non c’è interrogativo umano, non c’è passione o sentimento che la cultura greca antica non abbia affrontato o esplorato. L’ha fatto in modi e sedi diverse, l’ha fatto soprattutto con la grande letteratura – come non pensare ai poemi omerici o al teatro?! – ma l’ha fatto, ancor prima e ancor più, attraverso il mito, patrimonio antico e universale di un popolo intero, sostrato di qualsiasi manifestazione artistica.
Una mitologia, quella greca, che Cesare Pavese ha fatto propria al punto da poterne scrivere incrociando più livelli di intenti: esplorare l’uomo attraverso il mito ed esplorare il mito attraverso l’uomo, in ventisette dialoghi di uno splendore delicato, di una rara sensibilità e di una profondità sconvolgente.
Dialoghi, dunque. Voci di dèi, semidei e uomini. Voci di ninfe e titani. Ascoltiamo Circe, Tiresia, Eracle; ascoltiamo Saffo, Ariadne, Calipso. Ascoltiamo anche diverse entità: Eros conversa con Tànatos, Bia con Cratos. Frasi brevi, spesso lapidarie, che concentrano strati di significati in una manciata di parole – parole su cui hai bisogno di tornare, midolli di realtà che giri e rigiri dentro di te. E si parla di amore, di origine e di religione; di nostalgia, di vecchiaia, di morte, di passione. Della vita, dunque, semplicemente; e di noi, di noi tutti, perché la domanda, la grande domanda sottesa, è sempre chi siamo? E così, dando voce al mito per quello che è – esattamente per quello che è – Pavese svela del mito aspetti nascosti, regalandoci prospettive inattese di storie che appartengono al nostro immaginario, sfaccettature che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi ma su cui non abbiamo mai riflettuto.
E parlano sempre di noi questi dialoghi. Non solo quando a parlare sono uomini o quando si parla propriamente degli uomini: nel parlare degli dèi si parla di noi; anche nel parlare della dimensione arcaica primigenia si parla di noi.

Sì, perché il mondo è vecchio. Il mondo è più vecchio degli dèi.
I primi dialoghi in particolare rivelano un mondo antico, che rimarrà poi lì, a galleggiare e riecheggiare, quasi sospeso, per tutto il resto del libro, in contrapposizione a quello degli Olimpi ma a quest’ultimo sotteso. È il mondo del Caos primigenio, un mondo prima del tempo, il mondo favoloso – le cose stesse, regnavano allora – delle belve e dei boschi, del mare e del cielo, di lotta e di sangue; è la dimensione dell’indistinto, dove la nuvola la rupe la grotta hanno lo stesso nome, dove ogni entità è titanica e con loro, i Titani, domina l’irrazionale, l’ambiguo, la natura libera e ferina, mentre tutto è istinto, mentre i riti selvaggi spargono sangue.
Cos’era, a quell’epoca, l’Olimpo? Soltanto un monte brullo.
Poi è arrivato il regno degli dèi, gli immortali che hanno vinto i Titani, gli Olimpi che, rappresentando l’intelletto e la razionalità, hanno dato un nome alle cose, hanno messo ordine e portato una legge di giustizia – nulla si fa che non ritorni. Hanno vinto la selva, la terra e i suoi mostri, dice Eracle a Litierse, non hanno bisogno di sangue.
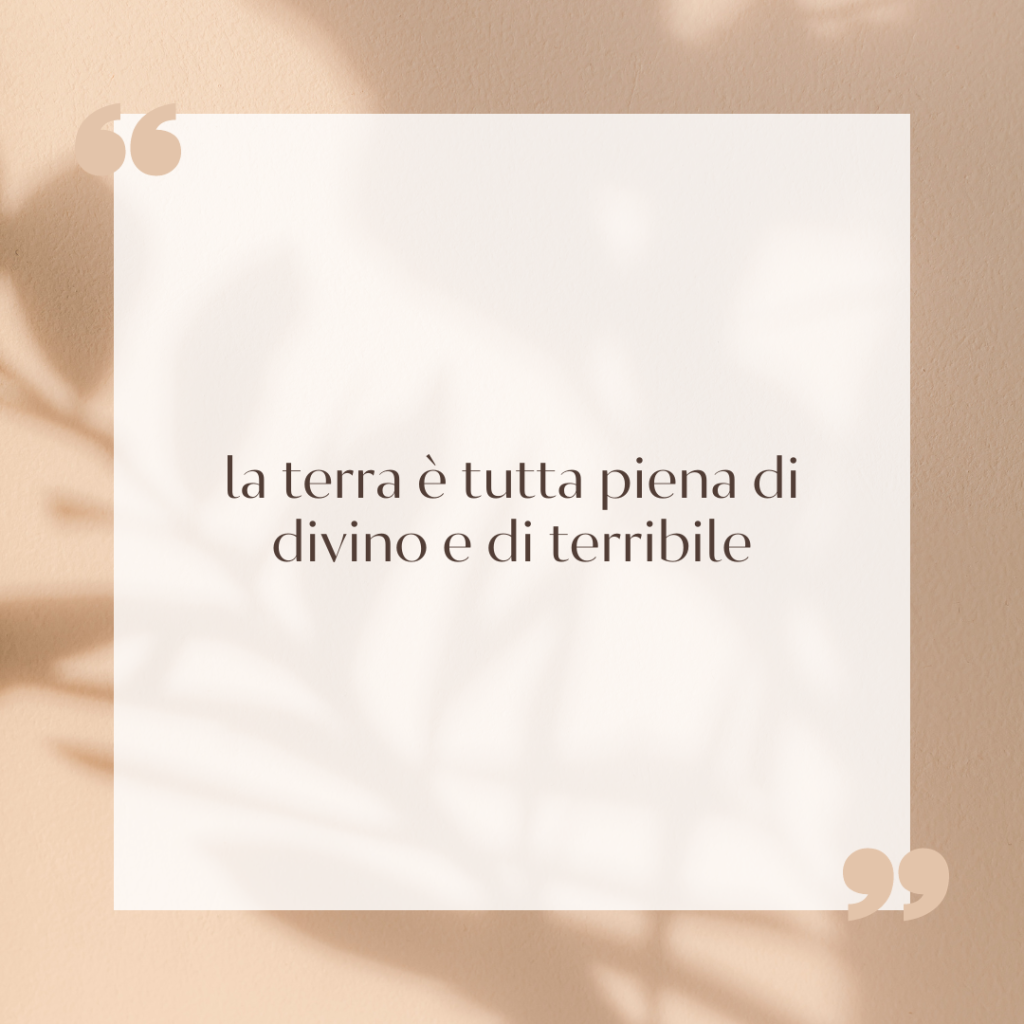
Ma cosa, quanto possiamo davvero attribuire agli dèi? È questa un’altra grande domanda che risuona ed echeggia. Per dirla con Tànatos, io mi chiedo fin dove gli Olimpici faranno il destino. E la verità, lo spiega Tiresia a Edipo, la verità è che il loro potere è limitato: posson dare fastidio, accostare o scostare le cose. Non toccarle, non mutarle. Sono venuti troppo tardi. Di conseguenza, come precisa Ermete, devon trafiggere e distruggere e rifare ogni volta che il caos trabocca alla luce, alla loro luce.
Ed eccolo, è qui l’intoppo: il caos trabocca. Trabocca perché la dimensione arcaica persiste, perché molte entità portano i segni di quell’era mostruosa, il ricordo del pantano, dell’informe furore sanguigno.
Forse è anche per questo che gli stessi dèi, pur forieri di un mondo ordinato, sono scossi da passioni distruttive; è anche per questo che possono agire per capriccio – o meglio, ancora con Tànatos, ogni loro capriccio è una legge fatale. Per esprimere un fiore distruggono un uomo. Possono essere ingiuriosi, loro che, come rimarca un cacciatore, non han rimorsi, tanto che i boschi sono pieni di uomini e donne da loro toccati – chi divenne cespuglio, chi uccello, chi lupo. La stessa Demetra lo ammette con Dioniso: io non so come, ma quel che ci esce dalle mani è sempre ambiguo.
Nulla si fa che non ritorni evoca la giustizia degli Olimpi, ma, allo stesso tempo, proprio perché nulla si fa che non ritorni, sangue porta sangue. Come rivela Prometeo a Eracle, il sangue dei mostri che l’eroe ha ucciso – quel sangue distruttivo rivivrà in lui e lo porterà a morire. Lo stesso concetto è espresso da Teseo: quel che si uccide si diventa, risponde l’uccisore del Minotauro al compagno che lo rimprovera di crudeltà. Non per niente, in un certo senso, non si uccidono, i mostri, e anche gli dèi Olimpi, ricordiamolo, li hanno soltanto vinti.

Arriviamo così al punto focale: i tre mondi – quello arcaico, quello olimpico e quello umano – in realtà convivono. E c’è una tale fluidità tra Titani e dèi e uomini che forse è tutta una questione di nomi, di idee, di paure. Le cose si mescolano, le cose si ripetono. D’altronde il caos umano-divino è, nell’idea di Pavese, la forma perenne della vita. Fluidità, mutabilità: identità. Che cos’era bestiale se la bestia era in noi come il dio?, si domanda Chirone. Quanto agli dèi, finiranno anche loro, decreta Prometeo, lapidario. E, per chiarire a Eracle, precisa: […] i mostri non muoiono. Quello che muore è la paura che t’incutono. Così è degli dèi. Quando i mortali non ne avranno più paura, gli dèi spariranno.
Torneranno i titani?, gli chiede Eracle.
E Prometeo: Non ritornano i sassi e le selve. Ci sono. Quel che è stato sarà. […] Siamo un nome, non altro. […] E il mondo ha stagioni come i campi e la terra. Ritorna l’inverno, ritorna l’estate. Chi può dire che la selva perisca? O che duri la stessa? Voi sarete i titani, fra poco.
Eracle: Noi mortali?
Prometeo: Voi mortali – o immortali, non conta.
Quello che conta, allora, è da dove arriva il divino. Arriva dai posti che abiti, che vivi; arriva da come cresci, dai valori che fai tuoi. E comunque, come rimarca Teseo, […] quel divino che hai nel sangue non si uccide.
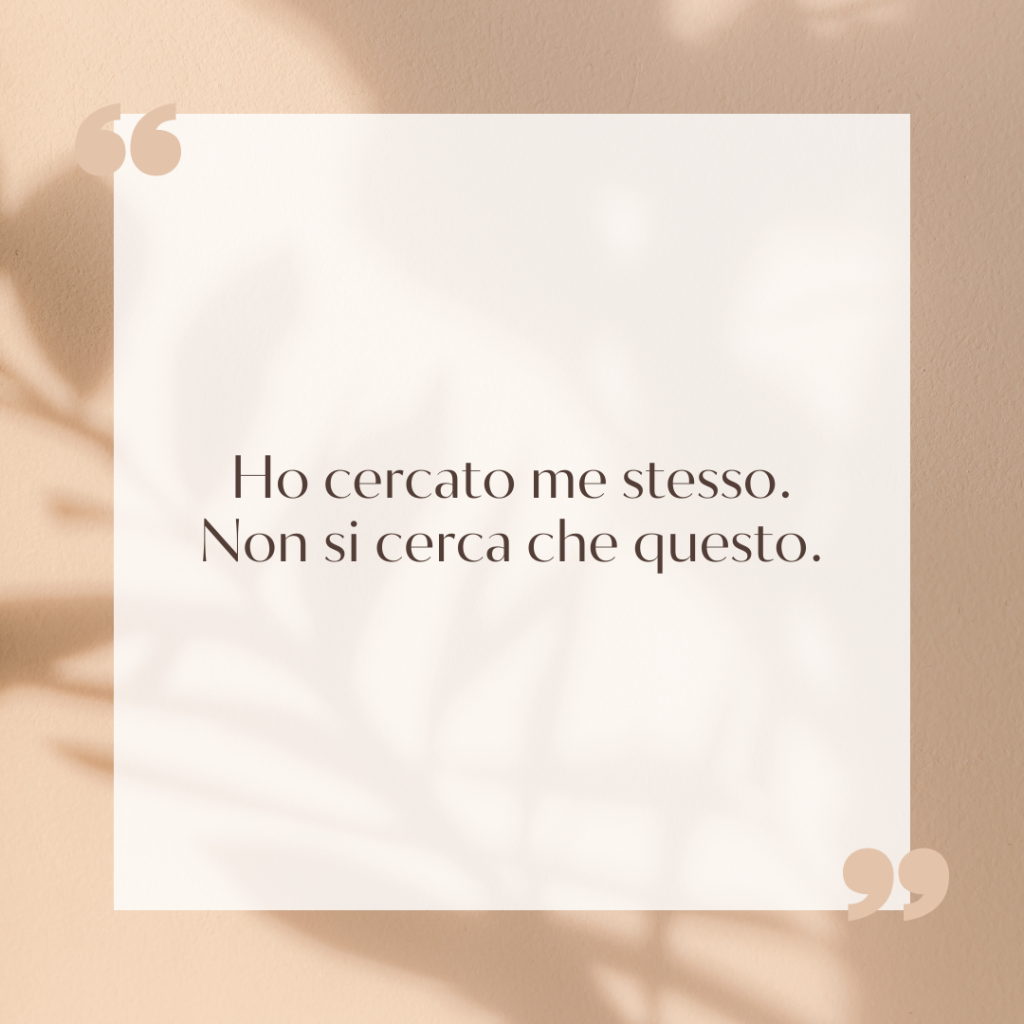
Il sangue. Ecco un’altra costante imprescindibile, dall’epoca del Caos primigenio – quando era misto a fango – al presente sospeso del libro, nel quale è strumento dell’uomo per omaggiare gli dèi, fino al momento in cui, come pronostica Dioniso, gli uomini lo vedranno nel vino cristiano.
Il sangue, quel che vi gonfia le vene e accende gli occhi, dice Diana a Virbio, so che è per voi vita e destino.
Destino – è questa l’altra parola chiave, è questo il cardine della riflessione sull’uomo e sul suo rapporto con la vita: il destino, avversato e detestato da alcuni; il destino, ricercato da altri come imprescindibile parte di sé, del proprio essere umano. Ho bisogno di avere una voce e un destino, dichiara Virbio a Diana, lamentando la condizione di estraneità dal tempo nella quale lei lo ha bloccato – quella felicità adamantina e finta che lo fa sentire un’ombra tra le ombre degli alberi – ed esprimendo nella chiusa finale – chiedo di vivere, non di essere felice – la necessità di una vita normale, magari difficile, ma umana. E se questo riecheggia, in qualche modo, nelle parole di Patroclo – meglio soffrire che non essere esistito – e nel discorso di Saffo, la quale, dopo il suicidio, realizza di preferire sofferenze e inquietudini alla monotonia di una morte che l’ha resa perenne schiuma d’onda, è passando per la sofferenza che Edipo, in uno dei dialoghi più commoventi, esprime la sua particolare visione della vita vera, il suo bisogno disperato di autodeterminarsi, di smarcarsi da quel destino a cui Virbio invece anelava in quanto umano: vorrei essere l’uomo più sozzo e più vile, afferma Edipo, purché quello che ho fatto l’avessi voluto. Non subìto così. Non compiuto volendo far altro.
Vivere, soffrire; accettare un destino o resistergli. Del resto, non è forse il destino la cosa più umana tra tutte? Così lo intende Orfeo: il destino, proclama, è più profondo del sangue, […] nessun dio può toccarlo. È cosa tua. Nell’originale interpretazione di Pavese, Orfeo cerca se stesso – non Euridice, ed è per questo che si volta, scegliendo di lasciarla andare – quando scende nell’Ade, e nel cercare se stesso cerca un destino. E quanto risuona, qui, Virbio! E quanto risuona Saffo, quando alla domanda di Britomarti sul destino risponde non l’accetto. Lo sono.
D’altronde, quello che cerco l’ho nel cuore, dice Odisseo a Calipso.
Accettare un destino o resistergli; soffrire, vivere. Vivere, sì. Perché la vita, la vita umana nella sua fragilità, nel suo costante moto di ricerca di sé, di lotta o armonia col destino, nelle sue passioni e in tutte le sue incertezze, possiede un’unicità che la rende più affascinante – e più vera, soprattutto – rispetto all’esistenza immobile nel tempo caratteristica degli dèi.
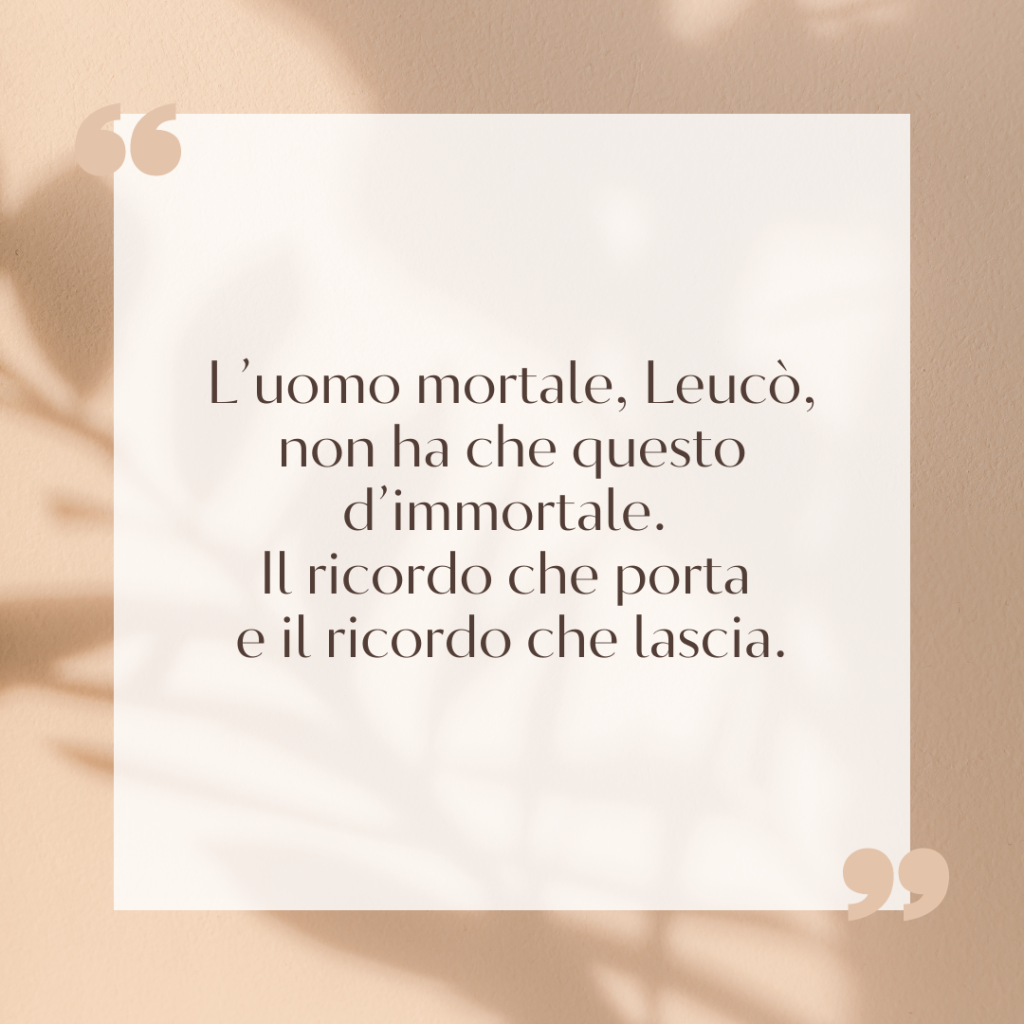
Sarà per questo che le divinità sono attratte dagli uomini? Che Artemide si innamora di Endimione e Bacco di Ariadne? Ancora, sarà per questo che i dialoghi dove un dio approccia un essere umano regalano le immagini più delicate? Come quella di Artemide, che nel toccare Endimione sui capelli, quasi esitando, viene colta da un sorriso incredibile, mortale, o come quando Dioniso, un dio per cui sorridere è come il respiro, sul punto di venire in soccorso di Ariadne è accostato da Leucotea a un paesaggio, un vigneto in costa a un colle lungo il mare, nell’ora lenta che la terra dà il suo odore, e poi a un profumo rasposo e tenace, tra di fico e di pino, e all’aria che pesa di mosto, e al frutto e fiore del melograno, e al fresco dell’edera, e ai pineti, e alle aie.
Ancora, c’è l’effetto che Odisseo fa a Circe, effetto che la maga stessa ci racconta in uno dei dialoghi più belli in assoluto, uno di quelli in cui guardiamo all’uomo con gli occhi di chi uomo non è, e in cui, per questo, emergono prospettive straordinarie di quella caducità che lo rende unico e inimitabile: la loro vita è così breve che non possono accettare di far cose già fatte o sapute, riflette Circe prima di mettere in luce quella facoltà – e insieme valore – che appartiene all’uomo e all’uomo soltanto, la memoria. E in questo dialogo, che sublima il potere del ricordo esaltandone la connessione con la dimensione affettiva, l’uomo risplende di possibilità estranee agli dèi – perché per lui il ricordo ha un significato, e perché è questo e solo questo a renderlo immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Una volta – racconta Circe a Leucotea, parlando di Odisseo – credetti di avergli spiegato perché la bestia è più vicina a noialtri immortali che non l’uomo intelligente e coraggioso. La bestia che mangia, che monta, e non ha memoria. Lui mi rispose che in patria lo attendeva un cane, un povero cane che forse era morto, e mi disse il suo nome. Sì, l’uomo dà un nome agli animali. L’uomo ama, e ricorda i suoi affetti. E quest’uomo amava un cane, una donna, suo figlio, e una nave per correre il mare. E con quella sua nave arricchiva la terra di parole e di fatti, incurante del destino che per questo, in qualche modo, riusciva a raggirare.
Sì, perché se è vero che agli uomini accadono cose inesorabili, è anche vero che queste cose sono fatte di assurdo, di attimi inattesi, irripetibili, sorprendenti, come – racconta ancora Circe – quel gioco degli scacchi che Odisseo m’insegnò, tutto regole e norme ma così bello e imprevisto, coi suoi pezzi d’avorio. Lui mi diceva sempre che quel gioco è la vita.
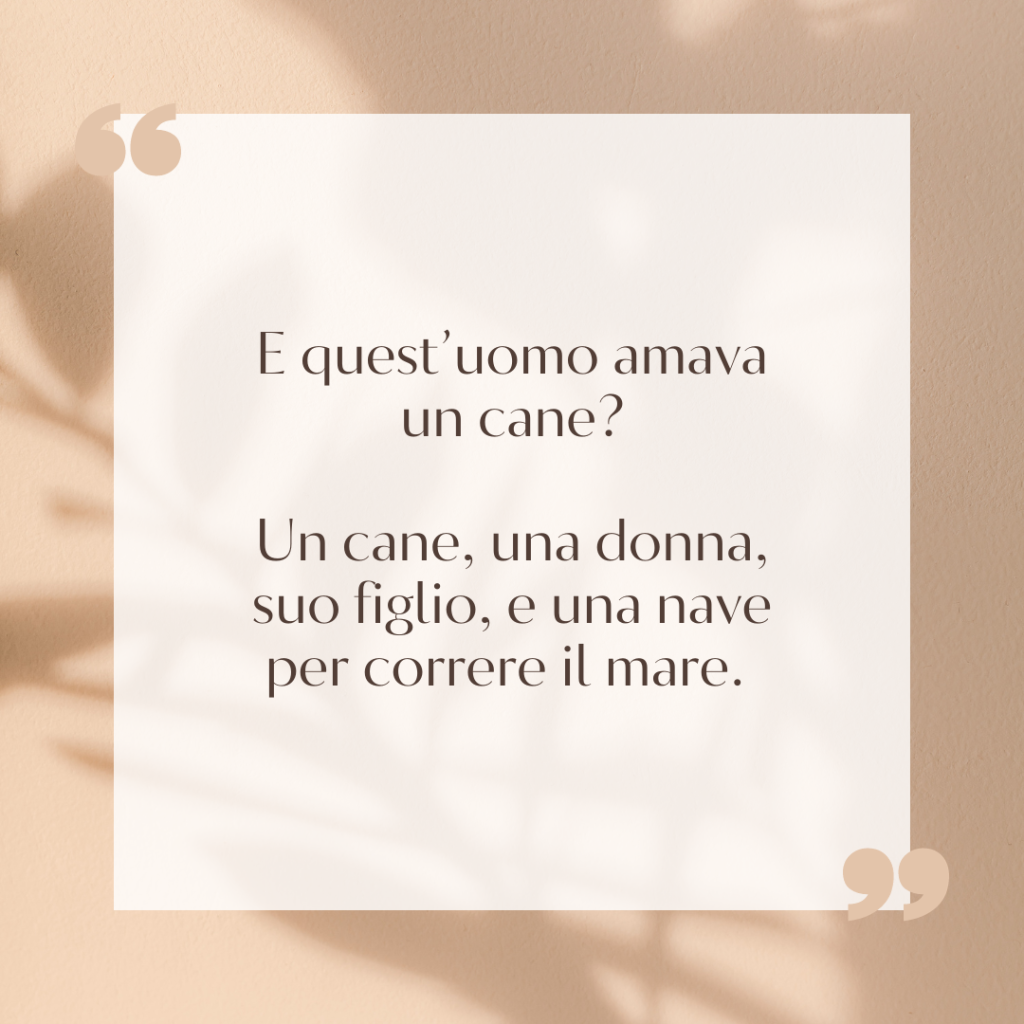
E così gli uomini vivono davvero, a dispetto del destino, e chi soccombe sono in realtà gli dèi, chiusi in un eterno presente – gli dèi che non esistono, ma semplicemente, come precisa Tànatos, sono, in un mondo che passa.
Senza di loro – senza gli uomini – mi chiedo che cosa sarebbero i giorni, riflette Dioniso con Demetra; tutto quello che toccano diventa tempo […] azione […] attesa e speranza, risponde lei poco dopo: ci troviamo nell’ultima parte del libro, pagine meravigliose che condensano e illuminano quanto di più buono ci sia nell’uomo – l’uomo, un essere creativo, coraggioso, fantasioso, capace di adattarsi e industriarsi, di nutrirsi di speranze e promesse e progetti – in una prospettiva di fiducia sul mondo, ma soprattutto in una celebrazione commovente della vita di noi tutti.
È quello che traspira, ad esempio, dalle parole di Cratos e Bia, di Dioniso e Demetra, di Satiro e Amadriade.
Perché Zeus e tutti gli altri dèi sono così attratti dall’uomo? La risposta è che il mondo, se pure non è più divino, proprio per questo è sempre nuovo e sempre ricco. Che questi umani sono poveri vermi, ma tutto fra loro è imprevisto e scoperta. Che sulle colline han saputo piantare vigneti, facendo dolci paesi di brutti pendii sassosi, e così hanno fatto del grano, così dei giardini, spendendo fatiche e parole e creando un ritmo, un senso, un riposo. Sono preziosi nelle labilità, straordinari nelle debolezze – preziosi e straordinari, soprattutto, per quegli istanti imprevisti, unici, che danno un senso vero alla vita. Per questo nella loro miseria hanno tanta ricchezza. Per questo, soltanto vivendo con loro e per loro si gusta il sapore del mondo.
Senza di loro mi chiedo […] che cosa saremmo noi Olimpici, dice ancora Dioniso. Ci chiamano con le loro vocette, e ci dànno dei nomi. E proprio la riflessione sul valore del nome torna più volte in queste ultime pagine: hanno un modo di nominare se stessi e le cose e noialtri che arricchisce la vita […] sanno darci dei nomi che ci rivelano a noi stessi […] e ci strappano alla greve eternità del destino per colorirci nei giorni e nei paesi dove siamo. È una capacità che afferisce, più in generale, a quella della parola – e la parola dell’uomo, che sa di patire e si affanna e possiede la terra, rivela a chi l’ascolta meraviglie.

E che dire delle storie che sanno raccontare?
Proprio su questo si chiude l’opera. Nel penultimo dialogo, non a caso quello tra Mnemosine e il poeta Esiodo, si riprende il tema della memoria, declinata stavolta nel suo potere di filtrare le immagini e addolcire le asperità e accostata, appunto, alla capacità dell’uomo di comunicare, di esprimersi, di portare la parola al mondo: è così che nasce la dimensione artistica, potere supremo dell’essere umano. Non per niente Esiodo incontra Mnemòsine – la memoria, madre delle Muse e quindi della conoscenza (mi par di sapere qualcosa soltanto con te, le dice) e di tutte le arti – su un monte: è il monte Elicona, sede delle Muse per i Greci, che situavano nei luoghi elevati le feste della fantasia e della memoria, assegnando al pensiero e all’arte una posizione di preminenza sul mondo.
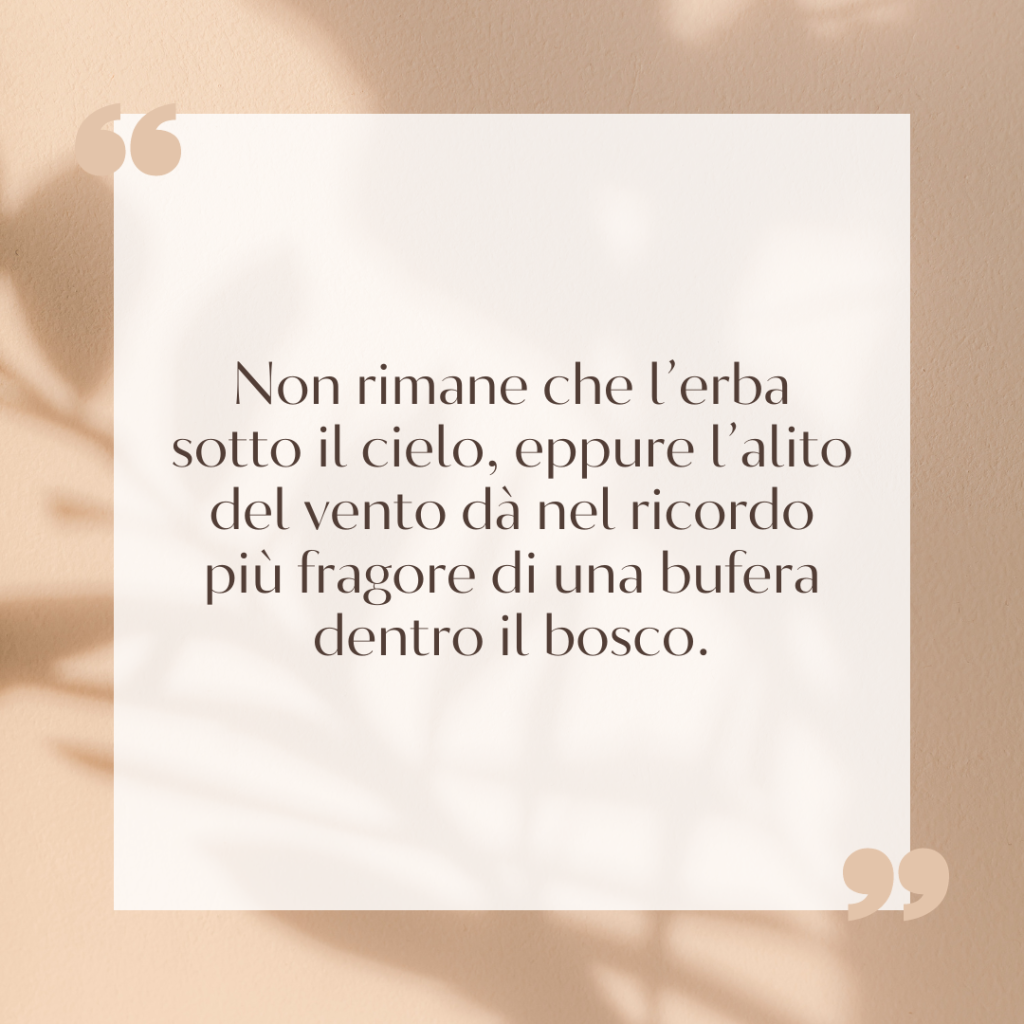
E su un monte è ambientato anche l’ultimo dialogo – su un monte brullo percorso, stavolta nella nostra epoca, da due interlocutori che discutono di mitologia. Perché, sì, quelle alture brulle sono così pregnanti di un passato mitico che basta un nonnulla, e la campagna ritorna la stessa di quando queste cose accadevano. Sono le alture dove i Greci hanno cercato, veduto, narrato quel patrimonio immenso di storie sull’umanità, lo spettacolo del mondo e dei moti del nostro animo – i Greci che sapevano troppe cose, che con un semplice nome raccontavano la nuvola, il bosco, i destini. È, ancora una volta, il potere di un nome che si carica di sostanze di significati: è il semplice, splendente potere della parola, che rivelando un midollo di realtà sorprende e scuote e fa tremare. E la parola è capace, lei e solo lei, di eternare questi luoghi donando loro nomi per sempre, laddove non rimane che l’erba sotto il cielo, eppure l’alito del vento dà nel ricordo più fragore di una bufera dentro il bosco. Per chi ci crede. Per chi crede in ciò che ogni uomo ha sperato e patito.
Non smetterò mai di leggere questi Dialoghi.
Se questo articolo ti è piaciuto e se ti interessano i classici della letteratura, puoi visitare la sezione del blog dedicata cliccando qui. 🙂
Carissima Arianna, che dire, un’analisi chiara, precisa ma che lascia spazio al lettore di approfondire il proprio sentimento e la personale ricerca del testo. Complimenti è sempre un piacere confrontarsi con i tuoi testi e commenti.
Grazie infinite per aver letto e grazie per questo commento. Sono davvero felice che tu abbia apprezzato!